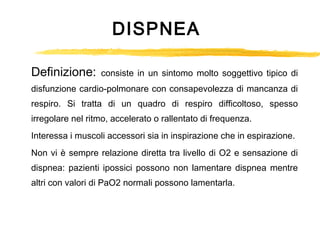
Dispnea
- 1. DISPNEA Definizione: consiste in un sintomo molto soggettivo tipico di disfunzione cardio-polmonare con consapevolezza di mancanza di respiro. Si tratta di un quadro di respiro difficoltoso, spesso irregolare nel ritmo, accelerato o rallentato di frequenza. Interessa i muscoli accessori sia in inspirazione che in espirazione. Non vi è sempre relazione diretta tra livello di O2 e sensazione di dispnea: pazienti ipossici possono non lamentare dispnea mentre altri con valori di PaO2 normali possono lamentarla.
- 2. DISPNEA Cronica: Acuta: Ostruzione acuta delle vie aeree Polmonite Sindrome da distress respiratorio PNX (pneumotorace) IMA (infarto miocardico acuto) BPCO Valvulopatie Scompenso cardiaco Anemie Rottura valvola mitrale IR (insufficienza renale) EPA (edema polmonare acuto) Disfunzione neuromuscolare
- 3. CLASSIFICAZIONE EZIOLOGICA 1. Vie aeree superiori corpi estranei, stenosi, tumori, reazioni allergiche, tracheomalacia 2. Polmoni e basse vie aeree asma, ipertensione, polmonite, ARDS, BPCO, tumori, versamento pleurico, EPA. 3. Ematologiche e metaboliche tireotossicosi, sepsi, febbre, anemia 4. Psicologiche astinenza, iperventilazione, attacchi di panico, ansia e depressione 5. Cardiache ischemia, scompenso, aritmia, valvulopatia 6. Neuromuscolari miastenia, miopatie, neuropatie, sindrome di Guillain-Barré
- 4. MECCANISMO FISIOPATOLOGICO Fase ventilatoria: insieme di processi che determinano il trasporto e il passaggio dei gas lungo le vie respiratorie, la loro distribuzione e il loro mescolamento; Fase di scambio: fenomeni di passaggio dell’O2 e della CO2 attraverso la membrana alveolocapillare; Fase di trasporto dei gas che rende possibile lo scambio e per la quale è indispensabile una corretta perfusione ematica del letto polmonare.
- 6. ACCERTAMENTO ANAMNESI ESAME OBIETTIVO PARAMETRI VITALI
- 7. SCALE DI VALUTAZIONE Scala MRC consiste in una scala che permette di orientarci in base alla gravità. Scala VAS valuta il dolore. Scala IADL valuta le attività di vita quotidiana come fare il bagno, vestirsi, toilette, spostarsi, continenza di feci ed urine, alimentazione Scala di BORG valutazione della dispnea durante l’esercizio. Scala NYHA valuta il grado di dispnea, suddivisa in 4 classi: 1.Assenza di dispnea a riposo e sotto-sforzo 2.Dispnea solo sotto-sforzo intenso 3.Dispnea con lievi sforzi 4.Dispnea a riposo
- 8. INDAGINI DIAGNOSTICHE PRIORITARIE RX STANDARD DEL TORACE TAC TORACE RMN TORACE SCINTIGRAFIA PERFUSIONALE SCINTIGRAFIA VENTILATORIA ANGIOGRAFIA ESAMI EMATICI
- 9. INDAGINI ENDOSCOPICHE Scopo diagnostico e Scopo terapeutico TORACENTESI CULTURA DELL’ESCREATO SPIROMETRIA TEST DI BRONCODILATAZIONE TEST DI PROVOCAZIONE BRONCHIALE L’EMOGASANALISI ARTERIOSA CRITERI EMOGASANALITICI LA PULSOSSIMETRIA
- 11. PRINCIPI SCIENTIFICI PER UNA CORRETTA RESPIRAZIONE Preparazione dell’ambiente e microclima: stanza del paziente deve essere ben pulita Occorre arieggiare spesso l’ambiente temperatura ideale sarà di giorno tra 18° e 21° C e di notte tra i 15° e i 18° C È necessario mantenere ben umidificato l’ambiente con appositi dispositivi È importante evitare la presenza di più persone nella stanza. Preparazione ed educazione del paziente: mobilizzazione precoce per evitare: ipossiemia, embolia, stasi venosa drenaggio posturale smettere di fumare tosse efficace nell’idratazione e umidificazione: os, ev, aerosol
- 12. OSSIGENO TERAPIA DEFINIZIONE Somministrazione di ossigeno al fine di permettere il miglioramento del livello della PaO2 nel sangue arterioso correggendo in tal modo l’ipossiemia (PaO2 >/= 60 mmHg), prevenendo la sofferenza tissutale attraverso l’utilizzo di appositi dispositivi.
- 13. OSSIGENO TERAPIA COMPLICANZE Tossicità del farmaco Secchezza delle mucose DISPOSITIVI Occhialini nasali Nausea, vomito e Vertigini Sondino naso-faringeo Dolore retrosternale Maschera facciale semplice Confusione mentale Venitimask con sistema venturi (alto flusso) Riduzione dell’attività mucociliare Riduzione dell’attività macrofagica Maschera facciale con reservoir (possibilità di eseguire l’alto flusso) Genesi di atelectasie Tende facciali Vasodilatazione polmonare Vasocostrizione sistemica Cappe ad ossigeno Riduzione dell’eritropoiesi Tende a ossigeno Riduzione della portata cardiaca Isolette neonatali e croupette Confusione mentale Dispositivi per ventilazione meccanica Cefalea Nel neonato fibroplasia retrolenticolare Nel BPCO riduzione o arresto della ventilazione
- 14. OSSIGENO TERAPIA POSSIBILI MANIFESTAZIONI DI INSUFFICIENZA RESPIRATORIA: Dispnea: inspiratoria, espiratoria o mista Posizione ortopnoica Fame d’aria Cianosi ( Hb desaturata > 5 g/dl) Agitazione,ansia, paura: sudore, tachicardia, pallore, ipertensione Coinvolgimento dei muscoli accessori Alitamento delle pinne nasali Sibili inspiratori Difficoltà nelle attività quotidiane Confusione mentale Rientro del giugulo
- 15. ASPIRAZIONE TRACHEO-BRONCHIALE Consiste nell’aspirazione meccanica delle secrezioni tracheobronchiali che si trovano nell’albero respiratorio, in modo particolare nel tratto tracheobronchiale. Le vie utilizzate sono la via orale, la via nasale e le protesi respiratorie come tubo endotracheale e tracheotomia.
- 16. ASPIRAZIONE TRACHEO-BRONCHIALE INDICAZIONI: Le secrezioni sono visibili nelle vie respiratorie All’auscultazione toracica si percepiscono gorgoglii, ronchi, diminuzione del murmure vescicolare Sospetto di aspirazione di materiale gastrico COMPLICANZE: Infezioni lesioni mucosa con sanguinamenti lesioni per eccessiva forza aspirativa ( non superiore a 150 mmHg nell’adulto), broncospasmo o laringospasmo Incremento del lavoro respiratorio turbe cardiache ed emodinamiche causate da stimolazione vagale Variazione dei parametri emogasanalitici tachicardie fibrillazioni o aritmie, Agitazione del paziente ipossia stimolazione del vomito.
- 17. ASPIRAZIONE TRACHEO-BRONCHIALE PRINCIPI SCIENTIFICI Utilizzare sondini in PVC trasparenti, di diametro dai 12 ai 18 gaus Aspirazioni non superiore a 10-15 secondi Non introdurre il sondino in fase aspirativa Misurare la lunghezza del sondino che deve essere introdotto, dal lobo dell’orecchio alla punta del naso a quattro dita sotto il giugulo Il calibro si decide nel caso di protesi respiratorie non superando la metà del calibro della protesi Nell’aspirazione delle secrezioni attraverso le vie naturali si rispetta al bassa carica microbica, per l’aspirazione tramite protesi ventilatorie è necessario garantire l’asepsi Eseguire una corretta igiene del cavo orale e delle narici per evitare la migrazione di agenti patogeni nelle basse vie aeree Iperossigenare il paziente prima di eseguire la manovra per ridurre le complicanze dell’ipossia, ponendo attenzione ai pazienti BPCO Lubrificazione con lubrificante idrosolubile Lavaggio del circuito con acqua bidistillata sterile
- 18. ASPIRAZIONE TRACHEO-BRONCHIALE CONTROLLO DEL PAZIENTE Prima, durante e dopo la procedure devono essere controllati i seguenti parametri: CONTROINDICAZIONI Vie nasali occluse o facile epistassi Epiglottite Rumori respiratori Colore della cute Trauma recente alla testa, alla faccia o al collo Schema e frequenza respiratoria Frequenza cardiaca Disturbi della coagulazione Saturimetria Pressione intracranica se possibile e se necessario Pressione arteriosa Colore, consistenza e quantità delle secrezioni Presenza di sanguinamento o traumi Tosse, Laringospasmo Laringospasmo, broncospasmo Irritazione delle vie aeree Infezioni delle vie aeree superiori Intervento chirurgico recente alla trachea con anastomosi alta Prime ore dopo un infarto miocardico
- 19. TRACHEOSTOMIA Procedura chirurgica eseguita in anestesia locale o generale per posizionare in trachea, a livello dei primi anelli tracheali un a cannula da lasciare per più giorni per consentire una comunicazione diretta tra vie aeree inferiori e ambiente si crea così, uno stoma artificiale abboccando la parete anteriore della trachea ai piani cutanei. La tracheostomia non è solo un dispositivo di ventilazione ma anche una modificazione dell’assetto anatomico della persona e della fisiologia.
- 20. TRACHEOSTOMIA GESTIONE ED EDUCAZIONE Sostituzione della cannula Alimentazione Tosse Rimozione della cannula tracheostomica Strumenti per parlare Educazione del paziente per la prevenzione delle complicanze
- 21. SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI ATTRAVERSO LA VIA INALATORIA Nebulizzatori per aerosol terapia Aerosol pre-dosati Istillazioni nasali
- 22. TERAPIA FARMACOLOGICA DECONGESTIONANTI SIMPATICOMIMETICI ANTISTAMINICI Per trattare le malattie delle vie aeree inferiori: BRONCODILATATORI gli agonisti adrenergici le metilxantine gli anticolinergici beta- ESPETTORANTI MUCOLITICI CORTICOSTEROIDI ANTITOSSIGENI ANTINFIAMMATORI RESPIRATORI ANTILEUCOTRIENI IMMUNOMODULATORI In caso di crisi d'asma sono usate le BENZODIAZEPINE I DIURETICI I GLICOSIDI DIGITALICI
Notas do Editor
- {}
