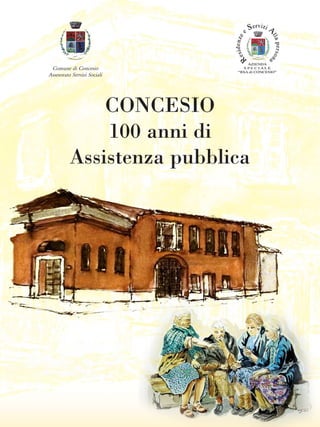
Concesio 100 anni di assistenza pubblica
- 1. Dpnvof!ej!Dpodftjp Bttftpsbup!Tfswj{j!Tpdjbmj CONCESIO 100 anni di Assistenza pubblica
- 3. CONCESIO 100 anni di Assistenza pubblica 3
- 5. „RSA DI CONCESIO‰ Assistenza e Solidarietà dal 1907 Un secolo di assistenza pubblica a Concesio, oltre un secolo di servizi alla prima infanzia ed agli anziani. Un commosso ringraziamento a Teresa Antonelli, illuminata da uno smisurato amore per l'umanità, che ha dedicato tutta una vita al servizio dei più bisognosi: bambini ed anziani. Un ringraziamento a tutte le Amministrazioni Comunali che si sono susseguite dal 1907 in poi: grazie per la partecipata dedizione al difficile compito ereditato dalla sig.ra Antonelli. Un grazie a tutti gli operatori che si sono adoperati per alleviare le sofferenze della parte più debole della nostra gente, anche attraversando le drammatiche turbolenze di ben due guerre mondiali. Grazie all'esercito di volontari che ha sostenuto, in silenzio, il lavoro degli operatori. Grazie a chi ha voluto, con tutte le forze, la costruzione della nuova Casa di Riposo, sostituendo l'ormai obsoleta struttura di via Sangervasio. Grazie a tutti coloro che, con le loro opere e la loro ostinazione, continuano a credere in un futuro intriso di solidarietà e di aiuto ai bisognosi. il Presidente dell'Azienda Speciale „RSA di Concesio‰ Ignazio Pau 5
- 6. 6
- 7. Dpodftjp Il Sindaco di Concesio 7
- 11. IL VOLONTARIO IN RSA Quando si prende in esame l'estrema complessità ed articolazione dei servizi assistenziali, fioriscono arti- colate statistiche di costi, utenti, quantità di prestazioni erogate, punti di forza, lamentele dell'utenza oltre alle immancabili prospettive di sviluppo con tanto di relazioni sulle azioni da intraprendere per miglio- rare la soddisfazione degli assistiti e l'efficienza della macchina organizzativa. In questo mare profondo di cifre, un attore che spesso sfugge alle mappature è il „volontario nelle RSA‰. Il volontario, si sa, non ha costi e ai nostri occhi, allenati alla palestra del moderno pensiero socio-eco- nomico, diventa trasparente. Ecco che allora, l'indagine sapientemente illustrata nel presente volume, ci fornisce uno speciale paio di occhiali che improvvisamente svelano davanti alla nostra vista una molti- tudine di individui che opera gratuitamente al fianco degli operatori di settore. A questo „esame della vista‰ si sono sottoposte tutte le otto RSA della Valle Trompia. Il progetto „Volontario in RSA: raccontare e raccontarsi‰ nasce da un'idea delle case di riposo della Valle Trompia, in stretta sinergia con Comunità Montana della Valle Trompia, con l'intento di accendere i riflettori su un mondo poco conosciuto, quello del volontariato in rsa, e cercare di capirne l'incidenza sulla qualità del servizio erogato dalle case di riposo in Valle Trompia. Il lavoro di ricerca, dal 2005 fino al 2008 ha coinvolto molti operatori ed un gran numero di volontari. Il progetto è stato sostenuto eco- nomicamente da Comunità Montana della Valle Trompia a cui va un doveroso ringraziamento. Una ristretta equipé di lavoro ha condotto uno studio durato più di due anni, sotto il coordinamento del dr. Lionello Anelli, direttore della RSA di Pezzaze. La presentazione della ricerca è avvenuta qualche mese fa presso la sala consiliare di Comunità Montana della Valle Trompia, a chiusura del terzo ciclo for- mativo per volontari in RSA. Ebbene, quella giornata rimarrà nella storia della nostra valle come il momento in cui la comunità ha preso coscienza della realtà del volontariato in RSA. Un esercito di volon- tari lavora gratuitamente per 73.930* ore all'anno nel complesso delle 8 RSA della valle. Se si volesse attri- buire un valore economico alle ore di lavoro regalate alla nostra comunità, dovremmo staccare un asse- gno da € 961.000,00*. Questa quantificazione, o se preferiamo materializzazione, dell'opera dei volonta- ri acquista ancora più spessore se la raffrontiamo al fatturato complessivo delle 8 RSA della valle che ammonta a poco più di 20 milioni di euro*. Il lavoro di ricerca ha messo in risalto anche tanti altri aspet- ti della preziosa opera del volontario. Questa pubblicazione riporta un'esaustiva raccolta del materiale prodotto nei due anni di ricerca. 11
- 12. In conclusione, una raccomandazione. Non lasciamoci abbagliare dalla ridondanza dei dati statisitci ed economici. Fare volontariato è molto di più che „far risparmiare‰. E' dono di sé agli altri. E' riconoscere nel bisogno e nella sofferenza un valore. E' prendere per mano qualcuno meno fortunato ed aiutarlo a rialzarsi, a riacquistare piena dignità. Non da ultimo, il volontario è la garanzia vivente della trasparenza di un'organizzazione di servizi. Infatti, non essendo al soldo di nessuno, il volontario è la coscienza cri- tica di un'organizzazione, è un punto di riferimento con cui nessuno si può rifiutare di confrontarsi, sia esso erogatore o beneficiario di servizi. Per l'ATI RSA della Valle Trompia Il Presidente dell'Ente Capofila Vincenzo Benedini * Valori riferiti all'anno 2006 12
- 13. I LUOGHI DELLA VECCHIAIA: Il PANE ED IL CASTIGO Lionello Anelli
- 15. La vecchiaia come emarginazione L a storia della vecchiaia è una storia più di separazione e di segregazione che non di integrazione e soc- corso. I vecchi sono, e sono sempre stati, cittadini diversi. I trattamenti nei loro confronti, abbastan- za ambivalenti, li hanno di volta in volta equiparati ai pazzi, ai mendicanti, ai malati infettivi. Per loro sono stati creati luoghi di accoglienza simili a ghetti, completamente separati dai luoghi di vita, dalle comunità. Ai pochi fortunati che hanno avuto la fortuna di essere accuditi amorevolmente dalle proprie famiglie o dai propri servi, perché agiati, si sono contrapposte intere legioni di derelitti dimenticati dalla storia, dai figli, dalle comunità di appartenenza. La storia della vecchiaia è una storia sostanzialmente di emarginazione. Simone de Beauvoir in un suo celebre saggio, divenuto ormai un classico della gerontolo- gia1, descrive efficacemente la considerazione che lÊOccidente progredito ha sempre riservato alla senilità: una considerazione nulla che cela lÊidea di una vecchiaia intesa come una malattia; un rapporto diseguale tra società e vecchi che considera questi ultimi come persone non aventi le esigenze e gli stessi diritti degli altri membri della collettività. Gli anziani sono stati deliberatamente condannati alla miseria, ai tuguri, alle malattie, alla disperazione. DÊaltro canto ogni cultura in ogni tempo storico ha esaltato le virtù della giovi- nezza associando ad essa il vigore, lÊazione, la dinamicità. Impossibile non pensare, e la storia contempora- nea purtroppo ci offre molteplici esempi, a tutto quel filone di retorica giovanilistica assai utilizzato a fini demagogici e propagandistici dai regimi totalitari, da quello fascista e nazista a quello maoista e via discor- rendo. Possiamo volgere lo sguardo a ritroso nei secoli e constatare quanto sia stato difficile esaltare le virtù della vecchiaia. Le rappresentazioni culturali e religiose dei popoli antichi sono eloquenti. Presso i Romani il dio Marte non è solo il dio della guerra, ma anche della giovinezza e della primavera, virtù guerriere e vigore giovanile vanno di pari passo. Per i Greci la divinità che presiede alla vecchiaia è posta in un Olimpo inferiore costituito da tutta una schiera di divinità e semidivinità abbastanza terrificanti: troviamo la dea Notte, della quale lo stesso Zeus prova un sacro timore, generatrice di dolorose figure come la Morte (Moro o Kene o Tanàto), il Sonno (Ipnos), il Lamento (Oizys) e, non a caso e in buona compagnia, la Vecchiaia (Geràs). Il primo lamento di un vecchio di cui si ha memoria risale a quattro millenni e mezzo fa, è un gemito di dolore frammisto a nobile rassegnazione: ComÊè penosa la fine del vecchio! SÊindebolisce un poÊ per giorno; gli si abbassa la vista, gli orecchi diventano sordi; la forza declina; il cuore non ha riposo; la bocca diventa silenziosa, non parla più. Le sue facoltà intellettuali diminuiscono e gli diven- ta impossibile ricordare oggi ciò che è accaduto ieri. Tutte le sue ossa dolgono. Le occupazioni a cui si dedicava prima con piacere diventano faticose, e quel che aveva- 15
- 16. Domenico Ghirlandaio (1449-1494) Ritratto di vecchio (s.d.). In questo bel ritratto del Ghirlandaio è presente la metafora del tempo che passa: il nonno (cioè il passato) guarda teneramente il nipotino (cioè il futuro). Il qua- dro è di un realismo notevole ed ispira buoni sentimenti. Ma non dimentichiamo che il committente di questo ritratto è persona ricca. La vecchiaia rappresentata, tra l’altro impietosamente se si notano i particolari delle escrescenze carnose sul volto del vecchio, è una vecchiaia di élite. È lecito supporre che questo anziano signore concluderà i suoi giorni nella sua bella magione attorniato dai servi. no di piacevole sparisce. La vecchiaia è il peggiore malan- no che possa affliggere un uomo2. Sono le parole di Ptah-Hotep, dignitario di corte del faraone Tzezi, scritte attorno al 2450 a.C.. Il lamento del vecchio scriba introduce nella sua affermazione finale un tema destinato ad avere un grande successo nei secoli a venire: la definizione della vecchiaia come un malanno, anzi, il peggiore malanno. Una concezione ripresa successivamente dai Romani, immortalata da Terenzio con il suo „senectus ipsa est morbus3‰ (la vecchiaia in sé è una malattia), che ritroveremo come motto nella scuola medica salernitana, e resa ancor più drammatica dallÊammonimento di Giovenale: „⁄ sed morte magis metuenda senectus4‰ (la vecchiaia è da temersi più della morte). La società romana teme la senescenza e tratta gli anziani duramente: solo lÊuomo nella sua età adulta è il vero motore della storia. Una cultura così connotata ha prodotto una sola opera apologetica sulla „terza età‰: il De senectute di Cicerone5. ˚ un fardello che ha pesato non poco sulla cultura occidentale. Presso la società medioevale nessuna data ufficiale segna lÊingresso nella „terza età‰, non esistono legislazio- ni previdenziali o età pensionabili: il vecchio diviene tale quando non è più in grado di svolgere la propria attività. Se il castellano può rimanere nella sua nobile magione fino alla fine dei suoi giorni, lo stesso non può dirsi del vecchio contadino che può contare solo sui suoi figli che non sempre sono teneri con le boc- che inutili6. Gli ospizi che in età moderna nascono in tutta Europa per accogliere vecchi e diseredati pur muovendosi con chiari intenti di carità e soccorso non riescono ad evitare lÊapplicazione di misure custodialistico-repres- sive. La storia della vecchiaia è una storia di esclusione e di luoghi di esclusione. Il primo rapporto tra invec- chiamento e società passa attraverso il sistema di valori che una comunità produce in un dato momento storico: „ogni società ha i vecchi che merita [⁄]. Ogni tipo di organizzazione socio-economica e culturale è responsabile del ruolo e dellÊimmagine dei vecchi. Ogni società secerne un modello ideale di uomo e lÊim- magine della vecchiaia, la sua svalutazione o valorizzazione, dipendono da questo7‰. Ne consegue che lÊOccidente, pur conservando una certa ambivalenza nei confronti della senescenza, sembra preferire la posi- zione gerontofòbica. In generale si può ragionevolmente supporre che la sorte dei vecchi dipenda dalla classe sociale di apparte- nenza ma, con alterne vicende, le società storiche occidentali non sembrano riservare loro particolari onori e privilegi. Nella società odierna prevale nei confronti dei vecchi l'indifferenza nonostante la retorica che popola le cro- nache dei giornali e della televisione. L'anziano ispira ripugnanza, non serve a niente, viene inferiorizzato. Può, tutt'al più, interessare ancora come consumatore e come elettore. Se lÊespressione artistica è lo specchio di una cultura, possiamo dire che il civilissimo Occidente non si è particolarmente prodigato nella rappresentazione reale e drammatica della „terza età‰. LÊarte occidentale sembra aver esplorato la vecchiaia, ma più come aspetto metaforico e simbolico che come reale condizione dellÊuomo. Così la scultura greca e romana ci restituisce non solo la perfezione dei corpi degli dei, dei guer- rieri e degli atleti, ma anche il volto della vecchiaia intesa come metafora del tempo che passa; una sorta di 16
- 17. Leonardo Da Vinci (1452-1519) Cinque caricature (1490). Le caricature leonardesche, forse è meglio parlare di ritratti accentuati, ritraggono volti grotteschi di vecchi anche se non manca mai nei suoi disegni lo sforzo di cogliere la psicologia dei personaggi. riflessione sulla vita e sui suoi affanni. Non interessa la condizione dei vecchi, ma ciò che essi rappresentano: quel „tempus fugit‰ (il tempo fugge) che vediamo inciso sui quadranti delle antiche meridiane. Gli intellettuali rinascimentali pongono lÊuomo al centro dellÊuniverso come baricentro di una perfezione ideale dimentichi dei limiti stessi della natura umana e della vecchiaia in particolar modo. In realtà il Rinascimento sembra voler combattere la vecchiaia, mai come in que- sto periodo proliferano trattati ad essa dedicati. Cortigiani, artigiani e umanisti sembrano osteggiarla, in fondo essa esprime il limite ultimo contro il quale si infrange lÊutopia dellÊuomo ideale. Gli splendidi dise- gni di Leonardo, tutti volti ad indagare la natura nelle sue leggi e nei suoi misteri, si soffermano su alcuni volti di vecchi. I ritratti leonarde- schi recano caratteri somatici fortemente accentuati, quasi caricaturali. La senescenza non è dunque solo un fenomeno da contrastare, reca in sé qualcosa di grottesco. Possiamo tuttÊal più soffermarci su ritratti, come quello del Ghirlandaio, che ritraggono un felice nonno abbrac- ciato al nipotino: unÊicona serena, voluta da una committenza ricca ed anziana, che non indaga il dramma della condizione della senescenza. Ed è così per tanti altri ritratti: la vecchiaia, di volta in volta, simbo- leggia la santità, lÊausterità, la saggezza, lÊopulenza, lo scorrere del tempo. ˚ necessario arrivare a tempi più vicini ai nostri per trovare qualche ritratto di vecchio calato nella dimensione reale, nella drammaticità della solitudine e dellÊemarginazione. Sino alle soglie dellÊetà contemporanea la vecchiaia non è considerata una categoria sociale. Gli anziani hanno la possibilità di essere soccorsi dalla carità privata solo se indigenti e solo se moralmente non cor- rotti. Sembrano essere questi gli elementi discriminanti che muovono le attenzioni delle istituzioni filan- tropiche. Anche lÊatteggiamento verso i poveri muta ed il passaggio dal medioevo allÊetà moderna segna in ciò una profonda demarcazione etica e concettuale. Tramonta la figura del povero rispettabile, affermatasi in epoca medievale, e si afferma quella del falso povero, del mendicante ozioso, del truffatore miserabile, di colui che non ha voglia di lavorare, di colui che sceglie lÊespediente allÊoccupazione onorata. La povertà viene ora vista con occhi diversi: la mendicità diviene fenomeno quasi ostile, da controllare e, se possibile, da reprimere. ˚ un atteggiamento che però cela in sé anche la necessità di restringere i costi di intervento, sempre più rilevanti, nei confronti della povertà dilagante. Tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento la sensibilità religiosa muta registro nei confronti della mendicità, ora il povero, ben lungi dal rappresentare lÊumiltà del Cristo, è un deviato che sceglie lÊaccattonaggio e non il lavoro: Questo mutamento culturale mutuato „dai ceti laici superiori‰, nonché sostenuto dagli scritti di grandi umanisti quali Erasmo da Rotterdam, Tommaso Moro, Jorge Luis Vives, condiviso nella sostanza dai protestanti come dai cattolici, fece sì che la gran massa dei poveri fosse divisa in due categorie: „vecchi e inabili‰, che dovevano essere rinchiusi in ospizi e ospedali, „otiosi‰ e vagabondi che dovevano essere obbli- gati a lavorare, pena la carcerazione, lÊespulsione dalla città, la frusta8. Tuttavia se da un lato vengono stigmatizzate la falsa mendicità e lÊozio, dallÊaltro non si può negare lÊesi- 17
- 18. Leonardo Da Vinci (1452-1519) Studi caricaturali (1487-1490). Un vecchio ed un giovane si guardano. Il vec- chio abbruttito dai segni del tempo; il giovane straordinariamente bello e con i tratti quasi femminei. Sotto un profilo squisitamente estetico la vecchiaia è vista in chiave negativa ed in fondo essa esprime il limite ultimo contro il quale si infrange l’utopia dell’uomo ideale. Gli splendidi disegni di Leonardo sembrano lì a dimostrarlo. stenza di una reale povertà. Di conseguenza lÊatteggiamento prevalente diviene quello di concentrare ogni provvedimento sociale ed ogni inter- vento caritativo solo ed esclusivamente ai cosiddetti „poveri veri‰, colo- ro che non sono reputati potenziamente pericolosi per la collettività, coloro che meritano di essere effettivamente aiutati. Nei ranghi dei pove- ri meritevoli troviamo i malati, gli inabili a lavoro, gli invalidi, i vecchi, vedove e bambini abbandonati da donne nubili sulle quali grava il mar- chio dellÊinfamia. Il benefattore può salvare la propria anima solo se la sua carità è rivolta alle persone giuste, cioè ai poveri veri; compiuto il proprio dovere morale, il ricco ha aperta la via per conquistare la sal- vezza. ˚ in questo modo che si concilia il denaro, lo „sterco del diavo- lo‰, con la religione. Nella folta schiera dei miserabili prende forma una figura particolare: il povero vergognoso. La caratteristica della povertà vergognosa è quella di non riguardare i mendicanti oziosi o pericolosi, ma coloro che versano in condizioni di miseria per la concomitanza di situazioni disgraziate e sfavorevoli. Un tracollo improvviso, una malattia, una concomitanza di situazioni sfortunate trasformano individui ben inseriti, fino al momento della crisi, allÊinterno della società (aristocratici, artigiani, mercan- ti) in nuovi poveri. Proprio per lÊoriginaria collocazione sociale, questi nuovi poveri si vergognano di chie- dere lÊelemosina o di pubblicizzare la loro miserevole condizione. Per loro la carità deve essere segreta e riser- vata. Il soccorso prestato ai poveri vergognosi diviene una sorta di atto solidale che le classi abbienti, domi- nanti nella scala sociale, riservano a coloro che una volta appartenevano ad esse stesse: una solidarietà tra simili in un rapporto simmetrico. La chiesa bene incarna il nuovo clima. ˚ da poco concluso il concilio tridentino quando Pio V, nel 1566, emana la bolla Cum primum, un provvedimento che proibisce lÊaccattonaggio nelle chiese, dove clero e fede- li non possono essere più disturbati dai lamenti dei mendicanti durante i riti religiosi. Ancora più energico è lÊintervento di Innocenzo XII che proprio con lÊemissione della bolla Ad exercitium pietatis, avvenuta il 20 maggio 1693, in continuità con gli interventi dei precedenti pontefici Pio V, Gregorio XIII e Sisto V, con- danna risolutamente la „vita laxa‰ dei mendicanti errabondi capaci solo di importunare i fedeli: „Distractionis fidelium aÊ divinis officis ob importunes mendicatium quaerimonias9‰. Si rafforza lÊidea che lÊozio conduca alla vita parassitaria, lÊozio padre di tutti i vizi, vizi che irrimediabilmente allontanano dagli ideali evangelici: Quasi unitamente alla bolla papale furono diffusi alcun libelli che meglio spiegavano come ci si dovesse comportare con i mendici. In uno di essi si legge ‰Conviene esa- minare se hanno lÊetà e le forze per guadagnare il pane ⁄ nel caso non bisogna stimarli come poveri ma mandarli a lavorare‰. Anche chi soffre mal caduco, febbre quartana, ovvero donna „gravida di sei o sette mesi„ può guadagnare una parte del nutrimento10. Tra la fine del Settecento e gli inizi dellÊOttocento prende avvio un processo di secolarizzazione della cari- tà11 che in Italia durerà per tutto il XIX secolo mentre il dibattito su come intervenire a soccorso delle masse più deboli si sposta da un piano etico-intellettuale ad uno più squisitamente politico. La grande diatriba vede due opposti schieramenti: i fautori della carità privata e quelli della carità legale (cioè sostenitori di un intervento pubblico). Il dibattito verte dunque su una precisa scelta di metodo e di politica: se lasciare che la miseria sia soccorsa dalle filantropiche iniziative di gruppi laici ed ecclesiastici oppure scegliere di desti- nare finanze pubbliche ed interventi legislativi a tutela e sollievo dei ceti meno fortunati. 18
- 19. Tra ordine pubblico e controllo sociale N ella Francia post-rivoluzionaria prende le mosse assai presto il processo di secolarizzazione della carità complice il mutato clima ideologico e la volontà laico-accentratrice della nuova amministra- zione. La Déclaration des droits del 1789 sancisce il diritto allÊassistenza che lo Stato deve riserva- re ad ogni cittadino. Nel 1798 le confraternite impegnate nellÊassistenza affidano la propria amministrazio- ne alle municipalità e queste, a loro volta, rendono conto direttamente al Ministero dellÊinterno. LÊesperienza francese è importante poiché trasferirà in Italia il proprio assetto culturale ed istituzionale. ˚ infatti sotto la dominazione francese che in Italia viene organizzato un primo sistema caritativo pubbli- co poggiante su Bureaux di beneficenza aventi il compito di elargire aiuti a domicilio12, su strutture ospe- daliere in grado di accogliere vecchi e poveri, su depositi di mendicità preposti ad ospitare mendicanti e vagabondi. Nel 1807 lÊattività delle Opere pie passa sotto la vigilanza del Ministero dellÊinterno il quale con- trolla ormai tutta lÊattività assistenziale. La presenza del Ministero quale supremo organo di gestione e con- trollo è fortemente correlata al persistere di una mentalità che ancora considera la povertà e la mendicità elementi di disturbo dellÊordine pubblico13. Sul quadro legislativo del periodo pesa ancora la tradizione e lÊimpostazione ideologica dellÊancien régime: „le norme, infatti, non fanno mai distinzione (o sono poco precise) tra intervento assistenziale rivolto agli anziani e intervento rivolto agli oziosi, vagabondi, accattoni, indigenti o ai poveri in genere14‰. Il crollo del potere napoleonico e la conseguente restaurazione frenano nel nostro paese lÊorientamento verso il soccorso pubblico. In Italia una prima presa di coscienza, seppur ancora generica, da parte delle autorità pubbliche riguardo al problema della „terza età‰ si ha con lÊintroduzione delle assicurazioni pensionistiche volute da Cavour15. Il diffondersi di fenomeni quali lÊurbanizzazione e il pauperismo, figli legittimi delle profonde trasformazio- ni socio-economiche introdotte dai primi fermenti di industrializzazione, costringono i governi pre-unitari a trovare nuove soluzioni ed a ipotizzare, visto che è ancora prematuro parlare di politiche sociali in senso stretto, politiche alternative di intervento assistenziale. Anche lÊamministrazione del Regno lombardo-veneto tiene desta lÊattenzione nei confronti dei problemi del- lÊassistenza pubblica orientandosi allÊemanazione di disposizioni sempre più organiche. ˚ proprio sotto la dominazione austriaca che vengono soppresse le Congregazioni di carità, creazione dellÊamministrazione napoleonica, e sostituite con la Commissione generale di beneficenza. Nel 1825 viene esteso il controllo del- lÊocchiuto governo austriaco su tutte le istituzioni di beneficenza ed istituita in ogni comune la Direzione elemosiniera. In realtà tra la legislazione napoleonica e quella lombardo-veneta vi sono più continuità che discontinuità. Sciogliendo le Congregazioni di carità ed istituendo gli Istituti elemosinieri, il governo austriaco non concede particolari aperture in senso autonomistico: sugli Istituti elemosinieri grava il peso di un controllo esercitato dalle Delegazioni provinciali e dal governo centrale, così come sulle 19
- 20. Congregazioni di carità era gravato il peso del controllo operato dalle Prefetture e dai Ministeri italici. Verso la povertà continua a permanere un atteggiamento ambivalente che porta a reprimere, anche duramente, un fenomeno quale la mendicità considerato un delitto contro la pubblica moralità, un elemento corruttore di costumi, un figlio degenere dellÊozio. Il codice penale austriaco emanato il 27 maggio 185216 contempla negli articoli che vanno dal numero 517 al 521 pene e contravvenzioni in relazione ai reati di questua. Contro i mendicanti recidivi lÊarticolo 517 sancisce che: Le misure da prendersi contro la mendicità sono connesse con le istituzioni di soccorso pei poveri, ed in generale spettano alle attribuzioni della Polizia locale. Il mendicare diventa per lÊaltro una contravvenzione allorché, esistendo istituti a soccorso dellÊindi- genza, taluno venga colto più volte in atto di mendicare, e dimostri così la sua incli- nazione allÊozio e lÊinefficacia della già fattagli ammonizione o del primo castigo17. LÊarticolo successivo stabilisce la pena di una tale infrazione nellÊarresto da otto giorni ad un mese con pos- sibilità di inasprimento „a misura dellÊincorregibilità del reo‰. Al suddito miserabile non resta che il ricor- so alle istituzioni di accoglienza ed ai ricoveri, strutture asilari peraltro più vicine agli istituti correzionali che alle case di accoglienza come noi oggi le conosciamo. Essere nullatenenti è ancora un problema di ordi- ne pubblico, una condizione di potenziale innesco di pericolosi fermenti e disordini. LÊaccattone è un diver- so, un elemento instabile del tessuto sociale e le autorità pubbliche nutrono nei suoi confronti sospetto e disprezzo. Non meno repressive saranno le leggi adottate dal nascente Regno dÊItalia: il Testo Unico di Pubblica Sicurezza, approvato con Legge 13 novembre 1859, n. 2248, proibisce la mendicità salvo formale autorizzazione rilasciata dalle autorità municipali e documentata da apposita lastra che il mendicante deve portare appesa al petto. Vecchiaia, mendicità e povertà continuano ad essere aspetti del medesimo problema: i mendicanti sono spes- so vecchi incapaci di provvedere a se stessi; nelle strutture di ricovero entrano quei vecchi, poveri e misera- bili, che non possono avere assistenza dalle proprie famiglie, oppure sono abbandonati dalle famiglie di ori- gine. ˚ unÊumanità emarginata e reietta, abbandonata non solo dalle famiglie, ma anche da ogni tipo di provvedimento legislativo sensibile alla loro condizione. Gli enti preposti dal canto loro, diversi per com- piti, finalità e risorse, non sempre riescono ad affrontare i problemi della varia umanità che richiede soc- corso e, quando lo fanno, spesso mostrano più lÊaspetto repressivo e custodialistico che non quello di puro soccorso filantropico. Se nel secolo dei Lumi assistiamo al tentativo di coniugare lÊidea di polizia e controllo sociale con unÊidea di filantropia e di bienfaisance nellÊottica di umanizzare il potere pubblico, nellÊOttocento sembra ormai affermata lÊidea che lo Stato debba intervenire in materia di assistenza. Ciò non vuol dire che vi sia lÊaffer- mazione generalizzata di un diritto soggettivo allÊassistenza, ma vi è la convinzione ormai diffusa che lo Stato debba avere un controllo ed un coordinamento delle istituzioni costituenti il sistema della beneficen- za. Sulle pagine di un giornale di epoca austriaca, il ÿLombardo-VenetoŸ, appare a metà Ottocento un emble- matico dibattito sulla beneficenza: Forse in niuna altra epoca della sua vita egli [il proletario] non ha maggiori diritti alla pubblica beneficenza; esso attende il compenso delle sue lunghe fatiche, dai copiosi sudori sparsi a prò della sua patria, e deÊ suoi simili. Le Case di ricovero e le Casse [sic] 20
- 21. Albrecht Dürer (1471-1528) Ritratto della madre (1514). Dürer ci ha lasciato uno dei disegni tra i più intensi della pittura moderna. In questo ritratto non vi sono simboli- smi: è semplicemente un figlio che ritrae la madre e lo fa con una bravura ed un tratto che sono eccezionali. È un ritratto che reca in sé una mestizia, una rassegnazio- ne: è il ritratto della vera vecchiaia, quella vissuta dalla stragrande maggioranza di persone che non appartengono ai ceti dominanti. È un ritratto che diviene anche una fonte di informazioni molto preziosa: la donna ha la fronte rugosa, il viso magro, le guance infossate, una strana divergenza oculare, sul suo viso c’è la fatica ed il lavoro, ma questa donna non è particolarmente vecchia. Sappiamo infatti che Dürer ha ritratto la madre all’età di 63 anni. Sono le fattezze di una donna invecchiata precocemente dalla fatica dopo aver messo al mondo ben 18 figli. Dürer era il terzogenito. È il volto di un’anzianità precoce, quella dei ceti meno abbienti. 21
- 22. Tra i vari compiti della Congregazione di carità vi era quello di assicurare la cura a domicilio dei malati poveri. La ditta Apollonio pubblica, attorno agli anni Ottanta dell’Ottocento, una piccola ed utile guida recante le tariffe dei principali medicinali e presidi chirurgici necessari all’assistenza medica domiciliare a favore dei cittadini indigenti. Questo piccolo prontuario era utilizzato dagli amministratori delle Congregazioni di carità (Archivio privato). di ritiro completano allora lÊopera socia- le, e il povero si muore benedicendo la società che gli prodigò le sue cure fino allÊutero materno, che lo educò alle arti con cui mangiare un pane onorato, che lo assistette nelle sue ultime infermità, e chiuse i suoi occhi con mano amorosa19. Il discorso, assai retorico come vuole la buona prosa del tempo, cela ancora un principio assai diffuso: parliamo di un diritto alla pubblica beneficenza prevalentemente, o esclusivamente, rivolto a coloro educa- ti „alle arti con cui mangiare un pane onorato‰, in buona sostanza ai poveri veri. Rimane e permane, dun- que, una discriminante di fondo tra coloro che sono rimasti nella miseria senza redenzione o per scelta e coloro, che pur nella miseria proletaria, hanno almeno una forma di riscatto. Ed è sostanzialmente per que- sti ultimi, i lavoratori anziani, che lÊanonimo autore invoca un sistema di beneficenza più coordinato ed efficiente: „noi guardiamo allÊavvenire e crediamo che vi possano essere mezzi idonei onde concentrare tutte queste Istituzioni in un solo sistema. [⁄] noi desideriamo anzi che particolarmente alcune tra queste rice- vano il loro pieno sviluppo, ma sempre sulla base di una legge uniforme, costante, per la quale si manten- ga quellÊaddentellato colle pie istituzioni generali20‰. Il dibattito generale sulla beneficenza entra nel vivo. In discussione non è più solo la natura di essa, se cioè debba essere pubblica o privata, ma si avverte lÊesigen- za di un intervento dellÊautorità pubblica con funzione di coordinamento e tutela delle varie istituzioni di beneficenza. Le Opere pie, enti privati di tradizione secolare che elargiscono beneficenza e soccorso a una moltitudine di malati e derelitti, sono lÊossatura del sistema di soccorso che mantiene un carattere privati- stico, cioè completamente svincolato dallÊintervento della finanza pubblica. Sono le Opere Pie, o Pii Luoghi, a gestire la variegata rete di strutture di accoglienza e ricovero: ospedali, manicomi, ospizi per vecchi e pove- ri, asili infantili, scuole agrarie, monti frumentari, brefotrofi ed altro ancora. Da più parti si invoca una razionalizzazione di tale sistema. Bisogna aspettare la nascita del Regno dÊItalia per addivenire ad un primo tentativo di riorganizzazione del settore. ˚ infatti con la Legge 3 agosto 1862, n. 75321, chiamata la „gran legge‰, che il settore assistenziale torna ad essere al centro dellÊattenzione istituzionale. LÊintento del legislatore è quello di unificare la normativa ita- liana sulle Opere pie emancipandole il più possibile dallÊingerenza governativa. La legge statuisce il disim- pegno della finanza di stato nei confronti del soccorso pubblico. Nuove istituzioni denominate Congregazioni di carità, soppiantando i precedenti Istituti elemosinieri, sono istituite in ogni comune con il preciso scopo di gestire tutti gli interventi di soccorso ai poveri e di esercitare un coordinamento sullÊat- tività svolta dalle Opere pie. Il sistema assistenziale definito dalla legge del 1862 regge per circa trentÊanni, fino allÊultimo decennio dellÊOttocento, quando il mai sopito dibattito politico sullÊassistenza unito alla volontà di riaffermare la supremazia dello Stato anche nei confronti della chiesa ed al riemergere della „questione sociale‰ portano ad un nuovo traguardo normativo: Francesco Crispi inaugura, nel 1889, una riforma del settore assisten- ziale che trova il proprio fondamento nella Legge 17 luglio 1890, n. 6972 resa successivamente pienamente operativa con il varo dei regolamenti attuativi tramite il Regio Decreto 5 febbraio 1891, n. 99. In virtù di questo provvedimento le Opere Pie divengono Istituzioni Pubbliche di Beneficenza22, soggetti di diritto pub- blico sui quali lo Stato può operare controlli patrimoniali. La ratio ultima della legge cerca di conciliare lÊin- 22
- 23. teresse pubblico, inteso come la razionalizzazione ed economicità degli interventi assistenziali, con lÊinte- resse privato inteso come la tutela della volontà dei fondatori delle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza. La legge impone lÊinquadramento sotto la forma giuridica di Istituzione Pubblica di Beneficenza nei confron- ti di qualunque ente che abbia „in tutto od in parte per fine: a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in ista- to di sanità quanto di malattia; b) di procurarne lÊeducazione, lÊistruzione, lÊavviamento a qualche profes- sione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico23‰. Le Congregazioni di Carità comunali continuano a sussistere ed a perseguire i propri fini istituzionali, anzi il loro ruolo ne esce rafforzato poiché „può essere concentrata nelle Congregazioni di carità qualsiasi istitu- zione di [assistenza e] beneficenza esistente nel Comune, e particolarmente le istituzioni che non abbiano una rendita netta superiore a 20.000 lire, o che siano a beneficio degli abitanti di uno o più Comuni24‰. Il provvedimento legislativo crispino ignora il problema del ricovero degli anziani e la strutturale carenza di strutture di accoglienza ad essi dedicate: il governo si limita a consigliare alle istituzioni locali la presa in carico dei casi più gravi. Anche qui, come in altri provvedimenti precedenti, lÊesigenza primaria è quella di non impegnare finanze pubbliche nel settore assistenziale. La carità legale è ancora lontana; il legislatore non ritiene opportuno destinarle risorse per il timore poi di imporre nuove tasse per sovvenzionarla. La legge crispina getta la basi di un assetto giuridico ed istituzionale il quale, sia pure con alcune modifiche, ha retto fino ai primissimi anni del Duemila. Il progredire dellÊindustrializzazione, le trasformazioni in atto, i mutamenti di ritmi e consuetudini, soprat- tutto nei grandi centri urbani, iniziano a connotare la vecchiaia come un fenomeno sociale e demografico a cui prestare attenzione. La mano privata non è più sufficiente. Nel 1898, momento cruciale per le riven- dicazioni politico-sociali25, è costituita la Cassa nazionale di previdenza per lÊinvalidità e la vecchiaia degli operai26. LÊimpegno pubblico è ancora lontano: la Cassa infatti è un ente autonomo. Ad essa possono iscri- versi tutti gli operai e le associazioni mutualistiche. I risultati non sono confortanti poiché non esiste obbli- go assicurativo, ma solo contributo volontario e le masse operaie non comprendono lÊutilità di una libera sottoscrizione. La previdenza volontaria è destinata al fallimento. Per i datori di lavoro lÊobbligo di finan- ziare la Cassa nazionale di previdenza si avrà solo con il D. Lgs 21 aprile 1919, n. 603. LÊattesa dunque dure- rà ancora ventÊanni. Intanto il fenomeno della vecchiaia, a cavallo tra il XIX ed il XX secolo, diviene sempre più oggetto siste- matico di studi scientifici. I cambiamenti socio-economici e le nuove spinte demografiche pongono la sene- scenza al centro di analisi epidemiologiche, statistiche, biologiche e mediche. Gli inizi del nuovo secolo, il cosiddetto „periodo giolittiano‰, sono caratterizzati da un indirizzo di governo più liberale e progressista. I livelli di alta conflittualità sociale sembrano gradualmente smorzarsi. A far pressione sui governi per unÊe- stensione della legislazione sociale e previdenziale scendono in campo socialisti, cattolici, Confederazione Generale del Lavoro (C.G.d.L.), cooperative e società di mutuo soccorso. La grande guerra blocca improvvisamente e drammaticamente questo fronte di rivendicazione politica ma contribuisce, dopo la sua conclusione, a far esplodere contraddizioni e rivendicazioni ponendo lÊurgenza di soluzioni indifferibili. Con Decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603 il governo istituisce lÊassicurazione obbligatoria per lÊin- validità e la vecchiaia. Il provvedimento è rivolto a tutti i lavoratori aventi unÊetà compresa tra i 15 ed i 65 anni. Alla contribuzione obbligatoria partecipano gli operai, i datori di lavoro e lo stato. Un traguardo importante è stato finalmente raggiunto. Il regime fascista introduce cambiamenti nel sistema previdenziale sancito dalla legge 603/1919 con un cam- mino legislativo che „porterà alla creazione di fondi autonomi, a trasformare trattamenti da integrativi a 23
- 24. Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale (I.N.F.P.S.) Domanda di assegno di natalità o di aborto (primissimi anni Quaranta). Alle iscritte presso la cassa I.N.F.P.S. era concesso richiedere l’assegno di natalità entro il termine di un anno dalla nascita del figlio mente l’assegno di aborto doveva essere richiesto entro trenta giorni dalla data dell’aborto. Il regime fascista costruisce tutta una serie di provvidenze a favore della maternità e dell’infanzia non dimostrando analoghe attenzioni nei confronti della terza età (Archivio privato). 24
- 25. La legge istitutiva dell’E.C.A. (Legge 3 giugno 1937, n. 847) com- mentata su una piccola guida amministrativa pubblicata dalla ditta Apollonio di Brescia ad uso delle amministrazioni degli enti locali (Archivio del Sistema Archivistico di Valle Trompia). La Legge Crispi ossia la Legge 17 luglio 1890 n. 6972, con il regola- mento attuativo disposto dal Regio Decreto 5 febbraio 1891 n. 99, pub- blicata su una piccola guida legislativa del 1901 (Archivio privato). 25
- 26. sostitutivi aprendo la strada alla diversificazione e alla sperequazione categoriale28‰. La filosofia di fondo oscilla tra a ricerca di un consenso sociale e la necessità di controllare e limitare il pauperismo; ogni inte- ressamento dello stato ubbidisce nuovamente a criteri di ordine pubblico e controllo sociale29. Il ruolo della carità privata è ancora incisivo e al di là della retorica populista di regime, il fascismo non sembra inten- zionato ad operare clamorose rotture con il passato. Al concetto di „beneficenza‰ il regime affianca quello di „assistenza‰, ma per gli anziani non vi sono particolari vantaggi: La beneficenza si estrinseca nei confronti del povero attraverso soccorsi materiali e in un arco di tempo breve. LÊassistenza si concretizza nei confronti di un individuo che, invece, deve essere „recuperato‰ e si articola in vari modi e in un arco di tempo più lungo. A tale individuo viene richiesta una partecipazione attiva al suo „recupero‰, al miglioramento della propria condizione. LÊanziano non può più essere „recuperato‰ per cui usufruisce della beneficenza. Assistenza significa dar vita a forme „preventive di beneficenza‰; assistere „soggetti a rischio‰. Beneficenza significa dar vita a interventi „lenitivi30‰. DÊaltro canto la missione del fascismo, ampiamente divulgata dalla retorica giovanilistica del tempo, è quel- la di forgiare la nuova razza; diviene quindi necessario impiegare tutti i mezzi nellÊeducazione dei giovani cittadini piuttosto che nel soccorso dei vecchi. La Carta del Lavoro, promulgata nel 1927 con lÊintento di organizzare il lavoro, lÊassistenza e la previdenza nellÊambito del nuovo stato corporativo fascista, non tocca in nessun punto il tema della vecchiaia. Con Regio Decreto 27 marzo 1933, n. 371 il regime codifica la pro- pria summa di legislazione sociale in un Testo Unico. LÊanno seguente è approvato, con Legge 1 marzo 1934, n. 766 lo statuto dellÊIstituto Nazionale Fascista di Previdenza Sociale (I.N.F.P.S.). Degna di menzione è invece, nel mare magnum dellÊattività legislativa fascista, la Legge 3 giugno 1937, n. 847 che sopprime le vecchie Congregazioni di Carità soppiantandole con gli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.), istituzioni assistenziali locali destinate a durare per qualche decennio. Tali nuovi enti acquisisco- no l'intero patrimonio delle Congregazioni di carità e, dotati di proprio statuto, si pongono lo scopo di „assistere gli individui e le famiglie che si trovino in condizioni di particolare necessità31‰ e di promuovere il coordinamento delle varie attività assistenziali esistenti nel comune. Gli E.C.A. sono amministrati da un comitato presieduto dal podestà coadiuvato da un rappresentante del fascio di combattimento, designato dal segretario del fascio, dalla segretaria del fascio femminile, esponenti delle associazioni sindacali nomi- nati dal prefetto32, composizione che ovviamente varierà dopo la caduta del regime fascista33. Il consegui- mento degli scopi assistenziali è assicurato „a) con le rendite del suo patrimonio e di quello delle istituzio- ni pubbliche di assistenza e beneficenza che esso amministra e che non siano destinate a particolari fini isti- tuzionali; b) colle somme che gli sono annualmente assegnate sul provento della addizionale istituita col Regio decreto legge 30 dicembre 1936, numero 217134‰ oltre che dalle somme che annualmente provengono dalle amministrazioni pubbliche e dai privati. I compiti dell'E.C.A. sono ampi, lÊutenza comprende bambini ed anziani, e si esplicano mediante l'eroga- zione di sussidi in denaro o in natura od il pagamento delle spese di ricovero. Di conseguenza molteplici sono le forme di intervento: pasti e soccorso invernale ai poveri, ricoveri notturni, invio di bambini biso- gnosi alle colonie marine e montane, assistenza ai poveri invalidi presso ospedali, ricoveri, istituti assisten- ziali, orfanotrofi, sussidi in denaro ai patronati scolastici, contributi ai disoccupati mediante erogazione di sussidi, generi di conforto o contributi in denaro. A livello di organico gli Enti Comunali di Assistenza non 26
- 27. Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto (1698-1767) I tre mendicanti (s.d.). Il Pitocchetto, presenza di rilievo nell’ar- te del Settecento, amava ritrarre la gente del popolo, i miserabili e di ognuno ne scopriva l’identità. Una scelta decisamente rivoluzionaria, questa, perché non era prerogativa delle classi misere avere un’identità ed una raffigurazione; ogni miserabile affogava fluidamente nel mare dell’anonimato, quasi della non-esistenza. Sono individui come quelli ritratti in questo quadro a rappresentare l’utenza delle Case d’Industria e di Mendicità. dispongono di personale proprio, ma impiegano il personale comuna- le opportunamente distaccato. Se da un lato il pesante fardello burocratico-assistenziale ereditato dal regime non facilita alla nuova Repubblica lÊadozione, almeno sul piano pratico, di formule estremamente innovative, dallÊaltro la cadu- ta delle opprimenti recinzioni ideologiche consente al nostro paese una certa permeabilità nei confronti di quei principi assistenziali e previ- denziali applicati nei paesi più evoluti. La Repubblica nasce anche con alcune sperimentazioni politiche e progettuali di indiscusso interesse. Basti pensare, per esempio, al governo provvisorio dei Comitati di Liberazione Nazionale (C.L.N.) ed in particolare allÊazione svolta dal C.L.N. regionale lombardo. Particolarmente intensa è stata allÊinterno del C.L.N. regionale lÊattività dei commissariati, istituti omologhi dei ministeri, ed in molti settori di intervento commissariale sono scaturi- ti progetti decisamente avanzati. Alcuni esempi: un principio di assi- stenza pubblica sburocratizzata fondata su ampio decentramento amministrativo; studi legislativi sulla riforma della previdenza sociale e sulla riforma dei codici di diritto e di procedura penale; progetti di autonomia per la scuola lombarda e soprattutto, una proposta di riforma sanitaria di respiro regionale che per modernità di impianto sembra anticipare lÊattuale ruolo in materia sanitaria svolto dalla Regione Lombardia e dalle A.S.L. locali. La sta- gione dei C.L.N. ha vita molto breve, ma il seme darà nel tempo qualche frutto. Lo sforzo principale della neonata Repubblica è quello di superare definitivamente il principio caritativo- elemosiniero, sancito da alcuni importanti articoli della nuova Costituzione, a favore di principi di sicu- rezza e protezione sociale applicati però in maniera ancora confusa. Nella pratica lÊorganizzazione previ- denziale ed assistenziale non subisce modifiche sostanziali; nellÊimmediato secondo dopoguerra permane un quadro complessivo estremamente frammentato ed arretrato caratterizzato da alcuni dati sconfortanti: „oltre 40.000 organi di livello nazionale, regionale, locale investiti di pubbliche funzioni in materia di assistenza (suddivisi su competenze dirette di ben 13 diversi ministeri35‰. Per quanto concerne il settore previdenziale sopravvive ancora per qualche tempo la Legge 1919/603 mentre lÊapparato assistenziale continua a ricono- scere come fondamento legislativo la legge Crispi definitivamente superata solo con la Legge 8 novembre 2000, n. 328. ˚ pur vero che in questÊultimo settore si sviluppa, proprio nel secondo dopoguerra, un dato di novità in senso organizzativo e concettuale: il servizio sociale. Esso, come ricorda Scassellati, conosce il suo periodo di sviluppo „tra il 1950 e il 1970 con la fase espansiva del ciclo economico del dopoguerra, che in Italia si caratterizza con due momenti: il primo del miracolo economico; il secondo della programmazione e del- lÊautunno caldo37‰. Proprio negli anni Settanta del secolo scorso, in un periodo di forte contestazione e con- flittualità sociale, si giunge al varo di un provvedimento legislativo che procederà ad una riforma del setto- re sanitario-assistenziale istituendo il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). Il provvedimento in questione è la Legge 23 dicembre 1978, n. 833. LÊattività legislativa conseguente inizierà a riservare unÊattenzione sem- pre più continua al problema degli anziani38. SullÊonda dei cambiamenti e del nuovo sistema assistenziale varato con le nuove leggi di settore gli E.C.A. vengono soppressi e le loro funzioni, competenze, personale e beni sono trasferiti al comune in cui gli enti medesimi avevano sede. Le leggi che decretano la fine degli Enti Comunali di Assistenza sono il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e la Legge Regionale 9 marzo 1978, n. 23. Si chiude definitivamente unÊepoca. 27
- 28. Angelo Morbelli (1854-1919) Festa di Natale dei dimenticati (1903). Un potente taglio di luce, quasi un raggio di vita e di salvezza, colpisce i vecchi seduti col capo sui banchi. Il senso di abbandono, di solitudine, di emarginazione è totale. In più vi è un elemento di silenziosa disperazione rappresentato dall’immagine di un vecchio che si staglia sullo sfondo con la braccia alzate contro il muro in un atteggiamento forse di pianto o forse di rabbiosa disperazione. È un’immagine terrificante dell’ospi- zio tardo ottocentesco. 28
- 29. I luoghi dell’accoglienza Con lÊetà moderna il controllo sociale è assicurato in due forme: la sorveglianza stretta sullÊaccattonaggio, attuato con il sistema delle licenze o patenti di mendicità39, e la segregazione. QuestÊultima assume i suoi connotati definitivi nel corso del Seicento, quando lÊisolamento dei poveri, successivo a quello dei lebbrosi dellÊetà medievale e contemporaneo a quello dei dementi, diventa un fenomeno diffuso in tutta Italia. Ci si convince che per risol- vere il problema dellÊindigenza sia indispensabile raccogliere tutti i miserabili allÊin- terno di enormi stabilimenti. Nascono così i grandi ospedali e gli alberghi dei poveri. La solita paura del diverso giustifica sul piano morale la reclusione di consistenti set- tori della popolazione europea40. A Roma, capitale della cristianità, verso la fine del Seicento risulta attivo lÊospizio sistino, una struttura asi- lare specializzata nellÊaccoglienza di vecchi indigenti, ma i criteri di accesso sono particolarmente rigidi: Per accedere a questÊultimo i mendici dovevano essere „esaminati‰ dai membri della congregazione. Dinanzi ad un notaio, oltre a dichiarare lÊetà, le persone anziane dava- no risposta a quattro domande: se avessero adempiuto allÊobbligo dei sacramenti e se erano a conoscenza delle principali preghiere, qualÊera stata la loro attività in passato e da quanto tempo risiedevano a Roma, se avevano figli e, infine, se erano in posses- so di denaro o di immobili. I registri che elencano e contengono questi „esami‰ rive- lano uno degli aspetti più duri della realtà romana [ma non solo] del tempo. Uomini e donne che, a causa dellÊetà non potevano più lavorare, abbandonati dai parenti più prossimi o rimasti soli, ai quali era rimasta una sola speranza: „vivere gli ultimi anni e morire‰ nel luogo di ricovero. Nella seconda metà del 1694, 101 vecchi ottennero il permesso di „vivere gli ultimi anni‰ nellÊospizio41. Il ricovero sistino è un modello esportabile in altre parti dÊItalia. LÊaccesso alle strutture di accoglienza non è mai automatico per gli emarginati, questi ultimi si devono „guadagnare‰ lÊattenzione delle istituzioni filan- tropiche e delle varie congregazioni deputate ai compiti di carità. LÊumanità sembra composta da due schie- re: coloro che possono essere redenti e coloro che non possono esserlo. Per incontrare il primo atto legislativo ufficiale in grado di delineare un modello istituzionale di interven- to assistenziale a favore della „terza età‰ dobbiamo spostare lo sguardo sulla storia inglese e tornare indie- tro di qualche anno. La legge in questione è il Poor Relief Act, emanata nel 1601. DÊora innanzi lÊesperienza 29
- 30. Angelo Morbelli (1854-1919) Giorno di festa (1892). L’immagine di questo quadro stride profondamente con il suo titolo:”Giorno di festa”. Anche qui la luce è solo accennata. Forse è lo stesso ambiente riprodotto nell’illu- strazione precedente ma visto da un’altra angolazione. Un quadro che diviene anche una fonte di informazioni, uno sguardo all’interno dei vecchi ospizi di cui abbiamo poche immagini e poche rappresentazioni. Gli anziani dell’ospizio indossano una divisa, un obbligo che si ritrova frequentemente nei regolamenti ottocenteschi. La divisa diviene il segno delle istituzioni totali (carceri, manicomi, riformatori, caserme) dove l’individuo è annulla- to, omologato, ridotto ad una piccola ed insignificante parte di un grande ingranaggio. anglo-sassone andrà distinguendosi per una maggiore sensibilità pubblica verso le tematiche assistenziali. Il Seicento è anche il periodo „in cui nasce a Parigi lÊHotel des Invalides. Per la prima volta nella storia, in questo secolo ÿpessimistaŸ, lo Stato si occupa in gran pompa dei suoi servitori dopo il loro ritiro, anche se solo di 1.500 eletti42‰. Il Poor Relief Act favorisce lÊistituzione di numerose strutture asilari e lÊinizio di un a nuova esperienza in materia di accoglienza: nascono in Inghilterra le Home Work o Workhouses, ricoveri per emarginati di vario tipo che assicurano ai propri ospiti vitto e alloggio in cambio di lavoro. Tale modello asilare si diffonde in tutta Europa generando istituzioni omologhe come lÊHôpital Géneral ed il Depôt Géneral in Francia, la Zachthaus in Germania, le Case dÊIndustria, di Ricovero e di Mendicità in Italia. Tra il XVIII e XIX secolo trova collocazione in tali strutture unÊutenza composita e disperata: vecchi e giovani indigenti, sovente dedi- ti allÊaccattonaggio, vagabondi senza fissa dimora, emarginati di vario tipo. Tra ottimismo razionalistico e slanci filantropici delle classi dominanti questi poveri derelitti sono ancora considerati una „merce‰ guasta da nascondere o da sanare ed il conseguente ricorso allÊistituzionalizzazione è fondamentalmente coatto e repressivo. Le strutture di ricovero ed accoglienza si adeguano alle leggi di pubblica sicurezza già molto seve- re nei confronti dei questuanti e dei vagabondi. Agli inizi dellÊOttocento, il secolo che segue il periodo „dei lumi‰ e che segnerà profondi cambiamenti nella storia europea, i vecchi poveri sono ancora dei cittadini senza patria. LÊarticolo 2 del capitolo settimo del Regolamento delle pie case di ricovero ed industria della regia città di Verona, una raccolta di norme redat- ta attorno al 1816, così recita: „Per tutte le altre mancanze i Ricoverati si puniscono o colla privazione della razione giornaliera di carne nei giorni di grasso, o di quella di formaggio od altro nei giorni di magro per tutto quel tempo che viene destinato dal Direttore, o con la reclusione nelle Sale di disciplina, o con lÊe- 30
- 31. spulsione finalmente dallo Stabilimento44‰. Nella civilissima Parigi, capitale di respiro europeo, ancora a metà Ottocento vige negli ospizi cittadini per poveri il ferreo criterio di separazione dei sessi: „La vecchiaia ritrova i suoi asili separati pei differenti sessi, ed anche uno ve nÊè ove due vecchi sposi possono starvi uniti e terminare agiatamente la loro carriera45‰. Dal tono con cui lÊautore si esprime, sembra che la possibilità di accogliere una coppia di vecchi sposi rap- presenti un servizio estremamente innovativo per il tempo, lÊeccezione che conferma la regola. Una lettura, anche superficiale, ai Regolamenti ottocenteschi di alcune istituzioni di ricovero lombarde ne svela la solida impostazione custodialistico-repressiva46. La rigida disciplina interna sancisce la separazione tra i sessi, lÊobbligo di indossare unÊuguale divisa per tutti gli ospiti, di portare capelli corti e barba rasata, legittima il mantenimento di camere di punizione e tollera delle sporadiche e brevi libere uscite. LÊimmagine che ne emerge è quella di una catena di istituti correzionali finalizzati al controllo sociale. Vale la pena citare alcuni stralci dai Regolamenti interni delle Case di accoglienza per avere unÊimmediata restituzione del rapporto ospite-istituzione; sembra di entrare in un bagno penale: Presso la casa dÊindustria di Como vi sono ÿdue sale di disciplina: lÊuna per gli uomi- ni; lÊaltra per le femmineŸ. Le punizioni sono comminate dallÊEconomo e variano da 1 a 5 giorni di detenzione. Il punito ÿviene privato degli alimenti, eccetto della por- zione di pane e dellÊacqua bisognevoleŸ. Tale punizione vale sia in ÿcaso di insubor- dinazioneŸ, sia per chi ÿpromuove disordini o atti contrari al buon costumeŸ, sia per chi ÿingiuria o percuote altro ricoveratoŸ, sia per chi ÿsi introduce in luogo riservato a diverso sessoŸ. Per tutte ÿle altre colpe o delittiŸ lÊospite viene tradotto davanti ai competenti tribunali. Nelle Pie Case di Ricovero di Milano è prevista ÿunÊassoluta fer- mezzaŸ per garantire ÿil rispetto della subordinazione, ovvero il cardine principale per mantenere la tranquillità e il buon ordineŸ. Viene punito chi si sottrae allÊobbligo di recarsi in chiesa o chi ÿesce prima del tempoŸ o chi promuove o intona discorsi o canti ÿcontro la Chiesa, il Sovrano e il suo Governo o contro le leggiŸ. Anche nel Ricovero di Mendicità di Milano vengono previsti trattamenti di segregazione, al limite a pane ed acqua. La comminazione delle pene spetta al Direttore. Al Pio Albergo Trivulzio le punizioni vanno dallÊammonizione, alla privazione del vino e del passeggio, alla per- dita del guadagno fino allÊespulsione. Simili punizioni sono previste anche nei Ricoveri di Brescia, Bergamo mentre in quello di Reggio Emilia vengono comminate pene anche in ÿcaso di trascuratezza del vestito, degli utensili, del lettoŸ47. Con il passare del tempo le Case di Lavoro e dÊIndustria sostituiscono alla loro funzione originaria di offri- re lavoro ai diseredati quella più propriamente assistenziale di ricovero e organizzano al loro interno infer- merie geriatriche in grado di accogliere malati cronici ed anziani. Sulle condizioni igieniche e di vivibilità di tutte queste strutture è difficile avere un quadro complessivo. ˚ lecito pensare che non tutte fossero in sufficienti condizioni se è vero, come è dimostrato, che anche nella nobile e civile Venezia la locale Casa di Ricovero lamenta, a metà Ottocento, lÊeccessiva vicinanza delle latrine ai dormitori e la poco funzionale con- vivenza tra allettati e deambulanti nelle stesse zone dormitorio. LÊistituto residenziale veneziano accoglie in questo periodo circa 760 ospiti, un numero consistente che pone necessariamente il problema della vivibi- lità degli spazi. Così si esprime il canonico Ambrosoli in una relazione del 1847: 31
- 32. Il certificato di povertà o attestato di miserabilità, rilasciato dal sindaco, conferiva al cittadino lo status di miserabile con conseguente possibilità di essere ammesso gratuitamente in strutture di accoglienza (ospizi, orfanotrofi, ospedali ecc.). Ancora oggi l’attestato di povertà rientra nelle certificazioni richieste dai comuni (Archivio Storico della Fondazione “Istituto Bregoli-O.N.L.U.S.”). 32
- 33. Oseremmo solo accennare ad un inconveniente, ed è la troppa prossimità delle latri- ne ai dormitori, che per altro abbondano di ventilatori ben distribuiti. Se la località si prestasse ad una riforma, io oserei proporre quella praticata a Genova nellÊalbergo dei poveri, ove senza aumento di disagio ai ricoverati è affatto impedita ogni esalazione negli ambienti del locale. Non accenneremo infine né alla promiscuità in uno stesso dormitorio dei decumbenti cogli ambulanti, né al cibo amministrato e spesso conser- vato nei dormitori, né al possibile tentativo di adoperare, non fossÊaltro per evitar delle noie, a qualche tenue lavoro quelle mani vecchie e storpie; giacchè sappiamo volersi appunto adoperare a queste riforme il nuovo fabbricato che si sta erigendo48. Non è difficile immaginare la vita nelle vecchie camerate dormitorio perennemente immerse in un effluvio di miasmi nauseabondi. Il problema dellÊigiene delle latrine in ospizi ed ospedali permane fino alle soglie del Novecento e le parole del dottor Canalis, pronunciate dalle pagine de ÿLÊIgiene ModernaŸ oltre mezzo secolo dopo, sono alquanto eloquenti: Tutti sappiamo che un cesso mal costrutto o mal tenuto, a parte lÊesalazione di gas nauseanti che rendono lÊaria meno respirabile e disgustosa, può essere una sorgente infettiva assai pericolosa di tifo, colera e dissenteria. Per convincercene non abbiamo che da visitare i cessi pubblici delle nostre stazioni ferroviarie [⁄]. Pur troppo nelle stesse condizioni delle latrine delle stazioni ferroviarie si trovano quelle di molte abi- tazioni collettive (ospizi, caserme, scuole, ospedali), dei vagoni ferroviari e di non poche abitazioni private. [⁄] Confessiamolo a nostra vergogna. Non è il nostro popo- lo ineducabile, siamo noi, classi cosidette dirigenti, che non abbiamo la pazienza di educarlo. Intanto, poiché non è possibile ottenere di botto quellÊeducazione che è frut- to di lunga propaganda, dobbiamo aumentare la vigilanza sulle latrine e specialmente su quelle delle abitazioni collettive49. Nel suo saggio intitolato Elogio della Vecchiaia, dato alle stampe nel 1895, il medico e scrittore Paolo Mantegazza tenta una rivalutazione della „terza età‰ in forma del tutto originale e nuova con lÊintenzione di rimuovere attorno ad essa quellÊalone di tragicità e dannazione propri del senso comune del tempo. Basta scorrere le pagine del libro dove Mantegazza delinea lÊimmagine del gerocomio ideale51, leggere al contrario ogni concetto utopico espresso dallÊautore, per rendersi conto della vera realtà dellÊospizio. Nello stesso periodo il pittore Angelo Morbelli realizza una serie di tele raffiguranti la desolante vita allÊinterno del Pio Albergo Trivulzio di Milano: sono immagini potenti di sofferenza, desolazione ed emarginazione. ˚ il volto terrificante dellÊospizio, quello vero e non utopico, ad essere rappresentato dal pennello di Morbelli. LÊOttocento è anche il secolo in cui, grazie ai generosi slanci della carità privata, si assiste nel territorio bre- sciano ad un rapido aumento di ospedali comunali. Tra il 1862 ed il 1920 sorgono nella nostra provincia 16 nuovi ospedali. Questi piccoli nosocomi devono però cimentarsi con gli alti costi della moderna prati- ca sanitaria che di fatto riduce sensibilmente la loro possibilità di intervento52. Si delinea così una rete di assistenza sanitaria, assai squilibrata qualitativamente e geograficamente, suddivisa tra ospedali cittadini, moderni nella gestione sanitaria ma sovraffollati nei reparti, ed i nosocomi comunali di provincia destina- ti ad accogliere prevalentemente pazienti affetti da infermità croniche al punto da divenire istituzioni ibri- de, a metà tra lÊospedale ed il ricovero, tra lÊambulatorio e lÊospizio. Sarà questa rete di nosocomi comuna- 33
- 34. li a trasformarsi, nel corso del Novecento, in strutture per anziani dando luogo al fondamento di quella che oggi conosciamo come la rete delle Case di Riposo. La funzionalità delle strutture di accoglienza per anziani inizia ad essere messa in seria discussione a caval- lo degli anni Quaranta del Novecento quando i progressi medici ed i germi della nascente disciplina geria- trica ne mettono a nudo lÊanacronismo e la disumanità. Con un simile retaggio alle spalle non stupisce, ma duole, che ancora oggi in forma gergale e dialettale la Casa di Riposo sia chiamata da molte persone non giovani con il termine „ricovero‰: lo spettro antico del luogo senza speranza continua a vivere nellÊimma- ginario di molti. Il secondo dopoguerra rappresenta uno spartiacque, un momento di svolta. Proprio nel periodo successivo al conflitto, in una fase di rinascita economica e sociale, inizia il tentativo di superare i tradizionali model- li istituzionali con uno sguardo attento a soluzioni meno totali se non addirittura extraistituzionali. Risale infatti ai primi anni del periodo post-bellico la nascita e lo sviluppo dei servizi domiciliari53 i quali, sorti inizialmente per offrire servizi alle famiglie, in un secondo tempo divengono, attorno agli anni Sessanta, servizi per anziani. Frattanto i trend di crescita della popolazione anziana spingono i governi occidentali non solo ad intervenire in forma legislativa e finanziaria sui servizi di Home Care, ma anche a considerare questi ultimi come alternativa allÊistituzionalizzazione sia sociale che sanitaria. In questo periodo, sopra le ceneri provocate dalla guerra, si ripristinano le strutture e le infrastrutture, ripar- te l'economia, si ricostruiscono i sistemi politici e sociali distrutti dal totalitarismo, si ricompongono le nazioni con nuove costituzioni tutte ispirate alla democrazia. L'obiettivo dell'affermazione dei diritti dei cit- tadini diventa uno degli scopi principali degli stati contemporanei, non solo dei diritti politici, ma anche dei diritti sociali. La Costituzione repubblicana italiana pone lo stato non più come lÊarbitro, ma come parte attiva nel garan- tire lÊuguaglianza dei cittadini. LÊarticolo 3 della carta costituzionale recita: „Compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impediscono lÊuguaglianza dei cittadini‰. Un principio deci- samente moderno ed avanzato. Ma tra lÊaffermazione dei diritti e la loro esigibilità effettiva bisognerà atten- dere ancora. Nonostante lÊincedere di una mutata sensibilità nei confronti degli anziani, il panorama gene- rale italiano relativo alle strutture di accoglienza si muove con estrema lentezza. Emerge, anche nei dibattiti nelle sedi istituzionali più alte, quanto il paese sia in ritardo ed inadeguato verso il mondo degli ospizi e quanto risulti difficilmente sradicabile il concetto di beneficenza a favore del più attuale e moderno concetto di assistenza. Il 12 aprile 1967 in seno ad un dibattito accesosi allÊinterno della II commissione parlamentare della camera dei deputati, il deputato La Bella alza la propria voce con paro- le che sintetizzano un clima di totale anacronismo: Il problema è [⁄] che non è più possibile continuare a prestare lÊassistenza in questa forma [elargizione di contributi in denaro], come se fosse beneficenza; la parola bene- ficenza deve essere cancellata dal nostro vocabolario, dato che lÊassistenza è un dovere della collettività nei confronti di chi ha bisogno, dovere sancito dalla Costituzione. Oggi la situazione in questo campo è (lasciatemelo dire) veramente drammatica; ho visitato recentemente alcuni ospizi per vecchi ed ho trovato che la loro situazione, il loro modo di vivere è veramente vergognoso per una nazione civile. I vecchi dovreb- bero concludere la loro vita in modo dignitoso e non certo nel modo in cui la con- cludono oggi in Italia54. 34
- 35. Le autorità pubbliche non sembrano cogliere lÊurgenza del cambiamento, o meglio, non dimostrano soler- zia nel dare concrete risposte ad una società che sta rapidamente mutando. Ancora nel 1968 una circolare del Ministero degli interni comunica: Bisogna promuovere lÊammodernamento della denominazione degli istituti che abbia- no ancora intitolazioni antiche e superate (mendicicomio, ospizio e simili) di talchè si pervenga nella generalità dei casi a una indicazione che non sia mortificante per la sensibilità degli assistiti e meglio si addica ai moderni principi dellÊassistenza sociale, quale quella di ÿcasa di riposoŸ, seguita eventualmente da altri nomi, come ad esem- pio quello del Santo protettore55. Una disposizione che non modifica nulla se non nellÊaspetto esteriore, allÊammodernamento delle denomi- nazioni non corrisponde quello delle strutture. Gli anni Cinquanta e Sessanta vivono spesso scontri sociali e tentativi di forte limitazione, basti ricordare le lotte per il lavoro o le riforme non concretizzate. Sono anni di profondi mutamenti sociali: il boom eco- nomico, le lotte operaie e studentesche che ampliano il campo dei diritti sociali e civili; l'entrata sulla scena delle regioni che allarga il quadro istituzionale. I cambiamenti economici, sociali, istituzionali e politici por- tano all'evoluzione del sistema sociale e allo sviluppo del cosiddetto Welfare State: cioè lo stato diviene pro- tagonista attivo delle politiche sociali. Negli anni Sessanta ancora manca una politica per l'anziano e questo soggetto resta uno degli esclusi da que- sto modello. Regna ancora molto centralismo e le nuove istituzioni, le regioni, non riescono allÊinizio ad esercitare un ruolo preciso nelle politiche sociali restando ancora lontane da bisogni delle comunità locali. Per quanto riguarda le strutture per anziani si può dire che esse, salvo eccezioni, rimangono ancora ferme al modello ottocentesco. Lo stato non investe in questo campo e le regioni sono lungi dal possedere chiari programmi e concrete risorse. Per attendere lÊinizio di un graduale e rilevante processo di metamorfosi degli ospizi è necessario attendere il varo della Legge 11 marzo 1988, n. 67 con il successivo D.P.C.M. 22 dicembre 1989 dove finalmente viene proposta una nuova tipologia di struttura: la Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.). La definizione del D.P.C.M. 22 dicembre 1989 così definisce la R.S.A.: Si definisce residenza sanitaria assistenziale una struttura extraospedaliera finalizzata a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero a persone anzia- ne prevalentemente non autosufficienti. Presupposto per la fruizione della residenza sanitaria assistenziale è la comprovata mancanza di un idoneo supporto familiare che consenta di erogare al domicilio i trattamenti sanitari continui e lÊassistenza necessa- ria56. La legge definisce anche i nuovi criteri strutturali cui devono ispirarsi le residenze per anziani: Il rispetto della condizione delle persone anziane accolte nelle residenze, sulla base delle analisi delle esigenze che esse presentano, nonché alla luce di esperienze italiane ed internazionali, implica una concezione architettonica e spaziale di tipo nuovo, atta a ricreare allÊinterno della struttura condizioni di vita ispirate a quelle godute dagli 35
- 36. ospiti al proprio domicilio. Le soluzioni progettuali se ne debbono fare carico, pro- ponendo la individuazione di spazi privati e personalizzati – articolati per piccoli nuclei di ospiti, di dimensioni modulari rispetto agli standard dei servizi appresso spe- cificati – e di spazi comuni per attività varie. Nel loro insieme le soluzioni debbono configurare, a scala di residenza, un tessuto abitativo articolato in cui siano presenti, accanto alle camere e alloggi, sostitutivi delle abitazioni, zone dedicate alle relazioni sociali, collegamenti tra le varie aree per agevolare la mobilità dei presenti e spazi riser- vati ad attività occupazionali e di laboratorio per impegnare fattivamente gli ospiti secondo le loro esperienze ed attitudini57. Siamo di fronte ad un concetto di tipo nuovo che mette finalmente lÊanziano al centro di ogni cosa, non più soggetto passivo di carità o di elemosina, ma soggetto attivo titolare di diritti: un cittadino come gli altri. La sigla R.S.A. sta a significare che innanzi tutto questa struttura ha carattere residenziale. La R.S.A. è per l'anziano una nuova residenza in cui si è trasferito, cambiando "solo" indirizzo senza perdere i suoi diritti di cittadino. Quindi al nuovo indirizzo dovrà ricostruire il suo ambiente dove dovrà vivere nel tempo che gli rimane. Pertanto lÊanziano porterà dentro la struttura il suo vissuto, le sue relazioni, i suoi affetti, coniugandoli con la nuova situazione e le nuove aspettative. La R.S.A. sembra essere molto vicina a quel concetto di gerocomio ideale formulato più di un secolo prima dallÊeclettico professor Paolo Mantegazza. Bisogna però giungere sino agli inizi degli anni Novanta per assistere alla fase più propriamente operativa. Il 30 gennaio 1992 il Parlamento approva una risoluzione che pone lÊavvio del progetto obiettivo naziona- le „Tutela della salute degli anziani‰ successivamente recepito dagli ordinamenti regionali, un programma dai molteplici punti qualificanti come: - la priorità degli interventi domiciliari; - lÊistituzione dellÊUnità di Valutazione Geriatria (U.V.G.)58; - lÊistituzione delle Residenze Sanitarie Assistenziali. Il legislatore pone così in essere una rivoluzione nel settore delle strutture di accoglienza per anziani rico- noscendo ai soggetti anziani una serie di bisogni ai quali rispondere con una molteplicità di servizi. Gli ele- menti qualificanti della R.S.A. sono da un lato la duplice valenza sanitaria ed assistenziale e dallÊaltro la pos- sibilità di inserirsi nella rete dei servizi territoriali per la terza età. Una scelta ispirata al modello delle nur- sing home, termine internazionale „che identifica strutture residenziali per soggetti disabili e dipendenti che necessitano di assistenza continuativa59‰. Più in specifico, il Progetto Obiettivo Anziani (P.O.A.) della Regione Lombardia definisce la R.S.A. come una struttura destinata alla riabilitazione generica di primo livello per anziani non autosufficienti, attività finalizzata a mantenere il paziente al più alto grado di autosufficienza possibile. Il P.O.A. sottolinea inoltre che i potenziali utenti sono persone che „non possono essere più assistite a domicilio e non presentano pato- logie acute o necessità riabilitative tali da richiedere il ricovero in ospedale o in istituti di riabilitazione (I.D.R.)‰. Gli obiettivi fondamentali della R.S.A. sono due: „rendere‰ il più possibile lÊambiente di vita simile a quello domestico: è questa la sostanziale differenza tra ospedale e R.S.A.; 36
- 37. strutturare lÊambiente in funzione della disabilità e dipendenza del paziente61. Negli ultimi anni molteplici elementi di rinnovamento hanno dunque mutato la fisionomia tradizionale delle vecchie Case di Riposo in maniera quasi radicale62 mentre un dato di fatto sembra ormai acquisito: il Geronte ha ed avrà un peso sempre più rilevante nella nostra società. Parallelamente a ciò lÊuomo anziano viene a trovarsi più che mai al centro dellÊattenzione di discipline che ne indagano lÊaspetto fisico-biologi- co, interiore ed etico. Ecco così la senescenza conquistarsi spazio sempre maggiore agli occhi della geronto- logia, della geriatria, della psicogeragogia, della gerotrascendenza e della tanatologia. Forse ha ragione Mario Barucci quando sostiene che „le soluzioni non devono essere trovate moltiplicando i servizi per i vecchi, ma insegnando ai giovani a prepararsi una vecchiaia che sia il più possibile indipendente dai servizi63‰. La popolazione mondiale aumenta ed invecchia ed il nostro paese è connotato come quello più „vecchio‰ tra le nazioni occidentali. Il processo di invecchiamento della popolazione nei paesi sviluppati dellÊOccidente ha assunto in Italia dal secondo dopoguerra ad oggi, per rapidità ed intensità, i tratti di un vero e proprio caso demografico. Se in passato la vecchiaia era il traguardo conseguente ad una dura sele- zione messa in atto da ostacoli socio-ambientali, lavorativi ed igienico-sanitari oggi, almeno nei paesi più sviluppati, non è più così. Alla soglia della terza età giunge ormai un alto numero di persone anche se, ai dati quantitativi riportati dalle statistiche demografiche non sempre corrispondono considerazioni confor- tanti sulla qualità di vita dei cittadini-anziani. Siamo un paese di longevi e dunque di vecchi: „Un peso così elevato degli anziani (attualmente una persona su cinque) è del tutto inedito nella storia dellÊumanità in popolazioni comparabili: una sfida completamente nuova per le società moderne. E lÊItalia sarà la punta avanzata di tale cambiamento64‰. Il regno dei Geronti porterà significativi cambiamenti. Come giustamente ha osservato Volpi „ci saranno tantissimi anziani al posto dei giovani che diventeranno sempre meno, le classi di età maggiormente ripro- duttive e produttive si assottiglieranno, gli squilibri demografico-territoriali si aggraveranno, e i problemi saranno tuttÊaltri da quelli di oggi, ma ancora più seri e difficili. Non è da escludere neppure che tra i pro- blemi che allora si presenteranno ci sarà anche quello di come fare a ricostituire una popolazione equili- brata per tornare a coltivare prospettive che non siano di sola sopravvivenza65‰. Le R.S.A. sono ormai inve- stite da un processo di evoluzione ed adattamento alle dinamiche sociali che può ritenersi a pieno titolo „incessante‰ se non, in alcuni casi, „logorante‰. La corsa ai nuovi adeguamenti ha imposto agli Enti Gestori delle Case di Riposo nuovi e pesanti oneri finanziari per la realizzazione dei nuovi Piani di Adeguamento voluti dalla Regione Lombardia. Risulta chiaro che, in un modo o nellÊaltro, gli Enti Gestori dovranno far quadrare i propri bilanci puntando su maggiori entrate e ricorrendo a tagli finanziari, se non allÊaumento delle rette di degenza. Le R.S.A., quali componenti ed attori del nuovo sistema di servizi, non potranno esi- mersi dal sottoporsi a quel processo di aziendalizzazione che è una caratteristica peculiare del welfare com- munity. La possibilità di sopravvivenza allÊinterno del sistema sarà strettamente dipendente dal livello di competitività espresso da ogni singolo attore, R.S.A. comprese. Nel contempo le Residenze per anziani dovranno trasformarsi in misura sempre più crescente da „luoghi di produzione monotona di residenziali- tà continuativa a Centri Multiservizi66‰. Gli ospizi sono ormai un lontano ricordo e le nuove strutture resi- denziali per anziani, simili sempre più ad ospedali e sempre meno a residenze, devono affrontare le nuove sfide, i cambiamenti sociali e quelli istituzionali, le nuove norme regionali, le nuove leggi di settore. Dopo secoli di stasi il quadro che si profila è quello di una piccola rivoluzione permanente. 37
- 38. NOTE 1 SIMONE DE BEAUVOIR, La terza età (titolo originale La vieillesse), Torino, Einaudi, 2002. 2 GEORGES MINOIS, Storia della vecchiaia. DallÊantichità al Rinascimento, Bari, Laterza, 1988, p. 18. 3 TERENZIO, Phormio, 4, I, 9. 4 GIOVENALE, Satirae, II, 45. 5 Per un approfondimento su questo tema si veda: UMBERTO MATTIOLI; Senectus: la vecchiaia nel mondo classico, Bo- logna, Patron, 1995. 6 La cultura medievale non di rado vede nel corpo il simbolo ossessivo di un immaginario collettivo: un corpo deforme, pre- cocemente invecchiato e corroso da mille morbi è il simbolo fatale di un universo corruttibile al quale non è dato sottrar- si. Sul tema vedasi: PIERO CAMPORESI, La carne impassibile. Salvezza e salute fra Medioevo e Controriforma, Milano, Il Saggiatore, 1991. 7 G. MINOIS, Storia della vecchiaia, cit., p. 10. 8 LUCIANO NASTO, „Nel serraglio dei birbanti il cibo deÊ poveri devÊesser parco‰. I primi quarantÊanni dellÊospizio di S.Michele degli invalidi, in AA.VV., LÊospedale dei pazzi di Roma dai papi al Â900, vol. II, a cura di FRANCA FEDELI BER- NARDINI, ANTONIO IARIA e ALESSANDRA BONFIGLI, Bari, Edizioni Dedalo, 1994, p. 339. 9 L. NASTO, „Nel serraglio dei birbanti il cibo deÊ poveri devÊesser parco‰, cit. p. 340. 10 L. NASTO, ibidem. 11 „Sono le esigenze centralizzatrici del nuovo Stato che si trova ad amministrare realtà economiche e sociali fortemente dif- ferenziate; sono le esigenze di controllo delle ÿmasse affamateŸ e, poi, di integrazione sociale quando tali masse invieranno in parlamento i propri rappresentanti che pilotano tale processo‰ (GUGLIELMO GIUMELLI, Anziani e assistenza. Dalla carità verso la sicurezza sociale, Milano, Franco Angeli, 1994, p. 59). 12 Gli aiuti consistono prevalentemente in indumenti e combustibile per lÊinverno. 13 La legge napoleonica del 20 agosto 1808 bandisce lÊaccattonaggio. 14 GUGLIELMO GIUMELLI-MASSIMO BOTTAZZI, Statuti e Regolamenti interni delle strutture di ricovero. Materiali per una storia dellÊassistenza in ÿMarginalità e societàŸ, n. 19, 1991, p. 74. 15 Convinto assertore dellÊutilità di una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia, Cavour lavora ad un progetto che si tramuta nella Legge 15 luglio 1859, n. 3595. La finalità è quella di assicurare alle classi lavoratrici più povere una rendita per la vec- chiaia senza pesare sullÊerario dello Stato. LÊistituto purtroppo non entrerà in funzione (G. GIUMELLI, Anziani e assistenza, cit., pp. 71-72). 16 Questo codice sostituisce il precedente emanato il 3 settembre 1803. 17 Codice Penale dei crimini, dei delitti e delle contravvenzioni colle ordinanze sulla competenza dei giudizi penali, e col rego- lamento sulla stampa del 27 maggio 1852 per lÊImpero dÊAustria (Das Strafgesetz über verbrechen, Vergehen und Uebertretungen, die Strafgerichts-Competenz-Verordnungen und die Press-Ordnung vom 27 Mai 1852 für das Kaiserthum Oesterreich), Vienna, I. R. Stamperia di Corte e di Stato, 1853, p. 180. 18 Ibidem. 19 Anonimo, Ordinamento della Pubblica Beneficenza, ÿIl Lombardo-VenetoŸ, Venezia, 1851, p. 14. 20 Anonimo, Ordinamento della Pubblica Beneficenza, ÿIl Lombardo-VenetoŸ, p. 15. 21 La „gran legge‰ si inserisce nel solco della tradizione legislativa sarda ricollegandosi alla normazione precedente: la Legge Rattazzi del 1859 ed un altro provvedimento legislativo varato nel 1850. 22 La denominazione di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) si avrà con il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841. 23 Articolo 1. 24 Articolo 54. 25 Nello stesso anno la rivolta degli operai milanesi, scoppiata tra il 3 ed il 9 maggio, viene soffocata nel sangue dalle unità regolari dellÊesercito agli ordini del generale Bava-Beccaris. 26 La Cassa è costituita con la Legge 17 luglio 1898, n. 350 alla quale seguono il regolamento esecutivo emanato con Regio Decreto 18 giugno 1899, n. 286 ed il regolamento tecnico approvato con la Legge 29 luglio 1900, n. 321. 27 Con Regio Decreto Legge 4 ottobre 1935, n. 1827, le norme relative all'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia sono riunite con quelle contro la tubercolosi, la disoccupazione involontaria, la nuzialità e la natalità, quest'ultima modificata 38
- 39. dalla Legge 26 agosto 1950, n. 860 in assicurazione per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, modificata poi con Legge 30 dicembre 1971, n. 1024. 28 G. GIUMELLI, Anziani e assistenza, cit., p. 147. 29 Anche nella legislazione fascista, come in quelle precedenti, il controllo e la repressione dellÊaccattonaggio sono totali. Il libro III del Codice Penale sotto il Titolo I, Capo I contiene lÊarticolo 670 il quale recita: „Chiunque mendica in luogo pub- blico o aperto al pubblico è punito con lÊarresto fino a tre mesi. La pena è dellÊarresto da uno a sei mesi se il fatto è com- messo in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare lÊaltrui pietà‰ (LORENZO DI DOMENICO, I cinque codici e le leggi connesse con lÊaggiunta delle Leggi Fasciste Fondamentali e del Trattato e Concordato fra la S. Sede e lÊItalia, Milano, Gorlini, 1934, p. 136). Molte volte il mendico è una persona anziana, per cui le sanzioni contro la mendicità sovente divengono atti persecutori contro la vecchiaia mise- rabile. In questo si evidenzia una continuità di principi ed applicazioni normative che legano la legislazione penale austria- ca (lombardo-veneta) con quella fascista. 30 G. GIUMELLI, Anziani e assistenza, cit., p. 148. 31 La istituzione dellÊEnte Comunale di Assistenza, Brescia, Apollonio, 1937, Art. 1, p. 6. 32 Ibidem. 33 Conseguentemente alla caduta del fascismo, i membri del comitato amministrativo dell'E.C.A. saranno nominati dal con- siglio comunale. 34 La istituzione dellÊEnte Comunale di Assistenza, cit., Art. 4, p. 7. 35 SILVIO CORAGLIA – GIOVANNI GARENA, LÊoperatore sociale. LÊazione professionale tra complessità sociale e fenome- ni organizzativi, Roma, la Nuova Italia Scientifica, 1996, p. 30. 36 Legge 8 novembre 2000, n. 328 „Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali‰. La suddetta legge detta nuovi principi per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. La sua effettiva applicazione è stata subordinata a tutta una serie di decreti emanati dal governo. 37 UBALDO SCASSELLATI, Profili per unÊanalisi storica sul servizio sociale in ÿLa rivista del servizio socialeŸ, n. 3, 1992, p. 80. 38 Citiamo solo a titolo di esempio i seguenti provvedimenti: Legge 23 ottobre 1985, n. 595; il Progetto Obiettivo Tutela della salute degli anziani approvato a stralcio del Piano Sanitario Nazionale il 30 gennaio 1992; D. P. R. 1 marzo 1994 (Approvazione del Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1994-1996); Progetto Obiettivo Anziani per il triennio 1995- 1997. Per quanto riguarda la normativa regionale citiamo: Legge Regionale 7 gennaio 1986, n. 1; Piano Socio Assistenziale 1988-1990; Legge Regionale 8 febbraio 1995 (Norme per il riordino del servizio socio-sanitario regionale). 39 Chi non possiede la patente è considerato vagabondo e dunque sottoposto alle leggi di polizia. 40 AUGUSTO CIUFFETTI, Povertà, assistenza e controllo in Italia; XVI-XX secolo, Roma, Morlacchi, 2004, p. 25. 41 L. NASTO, „Nel serraglio dei birbanti il cibo deÊ poveri devÊesser parco‰, cit. p. 342. 42 LUCIANO ANTICO, Una gerontologia senza pregiudizi in ÿAnziani oggiŸ, n. 4, 1992, p. 5. 43 Le Case di Lavoro e dÊIndustria nascono in Lombardia nel XVIII secolo e, affiancandosi alle esistenti Case di Ricovero, per- seguono lo scopo di fornire unÊeducazione al lavoro a quanti (accattoni, indigenti, oziosi ecc.) ne sono completamenti privi. LÊintento è quello di sradicare la piaga dellÊaccattonaggio e dellÊoziosità mediante un internamento poggiante su un inter- vento coercitivo di conversione obbligata allÊeducazione al lavoro. 44 GUGLIELMO GIUMELLI, Statuti e Regolamenti interni delle strutture di ricovero nellÊ800: un percorso di ricerca in ÿSenectusŸ, n. 1, 1994, p. 104. 45 A. BOUCHARDAT, Nuovo formulario magistrale preceduto da una notizia sopra gli spedali di Parigi e da generalità sulla maniera di comporre le formole, Palermo, Fratelli Pedone Lauriel, 1859. 46 G. GIUMELLI-M. BOTTAZZI, Statuti e Regolamenti interni delle strutture di ricovero. Materiali per una storia dellÊassi- stenza, cit., pp. 73-91. Gli Statuti ed i Regolamenti esaminati nel saggio di Giumelli e Bottazzi comprendono un arco di tempo che va dal 1802 al 1908 e si riferiscono ai seguenti istituti: Pie Case dÊIndustria S. Vincenzo in Prato, Milano; Pie Case dÊIndustria e di Ricovero, Milano; Casa di Ricovero e di Lavoro Volontario città di Como; Pie Case dÊIndustria e di Ricovero S. Marco e S. Vincenzo, Milano; Ricovero di Mendicità, Milano; Ricovero di Mendicità e Asilo Notturno „Mossi‰, Como; Pio Albergo Trivulzio, Milano; Casa di Ricovero e di Mendicità, Reggio Emilia; Ricovero Comunale di Mendicità, Brescia; Pie Case degli Incurabili, Abbiategrasso; Ricovero di Mendicità, Pavia; Ricovero di Mendicità, Bergamo; Opere Pie Asili Notturni, Milano; Opere Pie Asili Notturni „Lorenzo e Teresa‰, Milano; Opera Pia „G. Levi‰ per Ricoveri Notturni Gratuiti, Milano. 47 G. GIUMELLI-M. BOTTAZZI, Statuti e Regolamenti interni delle strutture di ricovero. Materiali per una storia dellÊassi- 39
